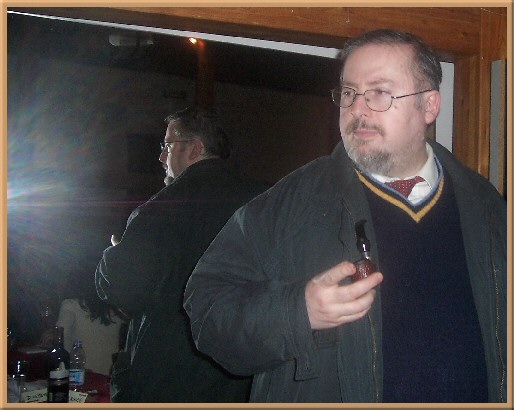PREMESSE PER UNA DIDATTICA DELLA POESIA.
Appunti poco popolari di un poeta.
di Davide Ferrari
Alcuni anni orsono l'allora Presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti ("Oh tempo-ra....") prese l'iniziativa di invitare a Montecitorio alcuni fra i principali "grandi viventi" della poesia italiana. Al termine del conto, l’iniziativa fu positiva.
Curiosa tuttavia la sigla che la RAI dedicò alla trasmissione TV dell'evento: immagini di gabbiani svolazzanti e di nuvole allo sfumo.
Certo Pivetti oltre non poteva andare. Ma è, forse, più generale pensare la poesia come qualco-sa fra lo spirituale e il trash. Anche nella scuola l'opinione diffusa è che la poesia sia un incom-primibile moto dell'animo e nulla più. Qualcosa che può essere insegnato solo da un professore stile "attimo fuggente". Un piccolo guru capace, senza mediazioni intellettuali oltre le proprie, di fare indossare ali di gabbiano ai ragazzi.
D'altra parte, al polo apparentemente opposto, la tradizione idealistica gentiliana, ancora così presente, consegnava alla poesia, nella scuola, una funzione - a ben guardare - poco dissimile. In quella visione la poesia, perla della cultura umanistica, è qualcosa che deve segnare il conte-nuto dell'educazione di una classe dirigente ed elitaria, la sola capace di afferrare l'emozioni più intime e profonde. Agli esclusi per destino e censo, nella scuola primaria, non resta che memo-rizzare e memorizzare.
Altro non c'è. Non stupisce che, ancora oggi, dati i punti di partenza e le egemonie in campo, poco sia radicata una "didattica della poesia".
Assistiamo a un vasto movimento nelle scuole, basta scorrere le occorrenze su Google per ac-corgersene, ma teoria poco si produce, i teorici sfuggono al compito.
E' possibile invece un punto di vista diverso che, ben compreso, possa essere il punto di parten-za per disegnare almeno alcuni elementi iniziali per un insegnamento dell'espressione poetica .
Si può afferrare un capo del filo e, da lì tirando e svolgendo, sbrogliare l'intricata matassa fra compiti di insegnamento e irriducibilità della creazione poetica..
Innanzi tutto poniamo le domande di sempre, quelle che Eugenio Montale ebbe a ripetere nel "discorso del Nobel" nell'ormai lontano '75. Che cos'è la poesia e se un senso possiede- se ne possiede- nella modernità?
Se "è del poeta il fin la meraviglia" come testimoniava il Marino, cominciamo con un'affer-mazione che, ancora oggi, può sorprendere: La poesia è forma..
Ciò che rende l'universale l'Infinito di Leopardi non è il suo contenuto. Se qualcuno scrive che, abitando nei pressi di Recanati è solito recarsi un colle e da lì guardare fin dove gli è possibile, non ci trasmette molto. La differenza fra queste parole e la straordinaria profondità del poeta universale è data dalla forma, dal meccanismo con il quale sono articolate le parole, oltre che dalla scelta, fra mille sinonimi, di certe parole al posto di altre, altrettanto possibili e significanti.
La parola poetica è qualcosa oltre la parola del quotidiano, per il potere particolare che ad es-sa conferisce la forma. Innanzitutto per il suo contenuto di musicalità e ritmo, per la caratteristi-ca di poter sospendere il tempo e di mutare la natura e la funzione del luogo nel quale la poesia viene prodotta o al quale ci riconduce.
Fin dalla più antica espressione umana, (par di vedere il piede dell’avo battere il ritmo sul ter-reno, mentre la parola che gli esce di bocca acquista -con la pronuncia e il metro- un valore e una forza specifici), la parola poetica avviene in e/o crea un luogo particolare.
Può trattarsi di un luogo naturale, sia esso il bosco dove il nume appare, sia esso il colle del dolore di Leopardi, oppure di un luogo sociale, una raccolta di uomini attorno a un'idea, a una preghiera, ad un evento o anche soltanto il recupero –che ogni volta si ripete e accomuna-dell'emozione di un classico nel ripercorrerlo leggendo. Altrimenti sarà un luogo dell'anima, per così dire, la creazione di un momento e di un'occasione dove la mente del lettore può ad-divenire ad un'astrazione di particolare intensità, tale da delocalizzarlo rispetto alla consuetudi-ne.
In sostanza la forma poetica è un codice fra il poeta e chi lo ascolto o lo legge. Quindi se la poesia è ispirazione, diciamo pure autonoma genialità, si esprime però con caratteristiche di necessaria esattezza senza le quali non è data.
Ma il partire dalla forma e dal termine di “codice” non vuol dire, in alcun modo, privilegia-re gli aspetti tecnico-letterari in un accostamento alla poesia.
Al contrario.
Il “codice” muta nel tempo e si impiega ad esprimere, così come capita a tutte le principali at-tività artistiche, ma con una forza di sintesi che ha nella letteratura soltanto la poesia , un tempo, un contesto storico, un paradigma culturale di cui il poeta è parte e di cui diviene, nella sua scrittura più alta, un tratto di esemplarità.
Ci avviciniamo un poco a temi che fondano un insegnamento.
Il poeta è sè stesso ma è nel legame con una "situazione", come asseriva il De Sanctis.
Gli antichi identificavano nell'intero arco della vita di un autore, di un artista, la cosiddetta "età della fioritura", gli anni della produttività felice della propria arte. Andiamo oltre e nell'età della fioritura poniamo mente ad una più ristretta "età dell'esemplarità". Saranno quegli “anni”, tal-volta un epoca, talvolta poco più di istanti, nei quali un poeta raggiunge la capacità di rappre-sentare, forse meglio di chiunque altro il paradigma culturale della sua età.
E' quel nocciolo della sua arte nel quale si esprime maggiormente il legame con la "situazio-ne", ma nel senso di una particolare raggiunta libertà di interpretarla.
Ciò che costruisce un poeta classico è proprio quel nocciolo, la sua estensione, la sua possibile comprensione, di generazione in generazione, da parte di un pubblico tendenzialmente univer-sale e mai esauribile.
La poesia come “parola potenziata”, il poeta come segnale del suo tempo, il "classico" co-me ineliminabile ed eterno segnale di "grado" nel succedersi dell'avventura umana: questi tre elementi non possono essere dimenticati, espunti, neanche nella modernità.
Con Montale dunque possiamo affermare, sia pure cercado di ricordare la sua ironia e il suo laico dubitare, che la poesia non può essere cancellata dalla nostra vita, neanche nella contem-poraneità turbinosa che attraversiamo.
Certamente il contemporaneo sembra a volte "il tempo del nulla". Quel "Nulla" che distrugge-va il regno di Fantasia della “Storia infinita” di Michael Ende.
Sono, i nostri, gli anni di un procedere, che pare invincibile, della crisi della funzione sociale dell'arte. Sono gli anni nei quali sembra espandersi sempre maggiormente la riproducibilità tecnica di ciò che un tempo era affidato solo all'opera dell’arsenale degli artisti.
Se, quando ne scriveva Benjamin, la pittura lasciava i suoi campi tecnici alla fotografia e al ci-nema oggi sono gli ipertesti e, pare, una grafica che presto potrà vivere incorporea persino dentro i nostri occhi, non solo nella nostra visualità, a conquistare il terreno.
Così per la poesia i luoghi di espressione della parola si sono moltiplicati a milioni e milioni, dai tubi catodici alle lavagne di internet.
La poesia e il poeta appaiono quindi con una funzione sociale indebolita e comunque meno ri-conosciuta dall'opinione pubblica e dal potere. Ciò conduce, come noto ad un isolamento della poesia d'arte, e, nel contempo all'esplosione quantitativa delle scritture individuali.
Quelle scritture figlie del tempo libero, diceva Montale, e, diremmo noi, di un disagio che non spetta più soltanto al figlio del conte Monaldo esprimere ma ad ogni "adolescente", anche trentenne, ai maestri di scuola come alle segretarie, alle casalinghe separate come agli eterni ragazzi in cerca dell'emozione irripetibile.
Sono, le loro scritture, un segno dell'epoca ma anche della sua debole autocoscienza collettiva . Quei fogli riempirebbero mille biblioteche di Alessandria, quei fogli neppure la catastrofe ato-mica potrebbe eliminare, come il poeta “premio Nobel “ci ricordava, mentre bastò un falò di pochi giorni a cancellare lo scrigno della classicità in quell'antico archivio del mondo della città del Faro.
Tuttavia , ripetiamo, seppure indebolita, la funzione della poesia è ineliminabile. Altrettanto ineliminabile sarà quindi il suo posto nella scuola, se scuola sarà.
Fondati motivi lo confermano. La forma della poesia, lo abbiamo già scritto, contiene verbalità e non verbalità, è un codice di particolare potere che allarga e mescola i linguaggi, come escluderlo dalla scuola? Come escluderlo dalla scuola primaria, laddove può rappresentare una sorgente della genesi stessa delle capacità di linguaggio del bambino e della bambina? Ma come escluderla anche nella scuola secondaria, dove le sue note di sinteticità sembrano parti-colarmente adatte alla comprensione ed all'allargamento intellettuale dei soggetti in età evoluti-va, del loro procedere esistenziale per salti logici e per sconvolgenti domande di senso.
E infine rimane comunque, al di là dell’ambito del nostro presente argomentare, il “peso”, nella storia della cultura italiana, della cultura umanistica e letteraria signoreggiata dalla grande catena dei poeti della"lingua del si". In fondo è sempre vero che furono i poeti a fondare, ca-nonizzare, imporre la nostra lingua nazionale.
Ma il contenuto formale del codice poetico, la sua esattezza, la sua ricerca di essenzialità, il le-game fra autore e "situazione", il ruolo storico della poesia italiana, “tutto” in sostanza, ci porta ad approfondire la ricerca di una didattica tutt'affatto contraria all'attualismo, alla mistica del rapporto diretto ragazzo/testo, alla post-modernità d'accatto.
Sono cattivi maestri, certo pessimi didatti, a me pare, quelli che volendo affermare la forza dello spirito in un testo, in un autore, commettono il delitto di togliere allo studente il diritto a una reale comprensione, non aiutandolo ad allargarsi, a “portare dentro di se” la forza del poeta che legge e impara a conoscere.
Non stupisce però che pochi siano i testi di riferimento di una adeguata didattica della poesia. A Gentile non servivano per i post-moderni sarebbe troppo faticoso scriverli.
Se è sempre stato più chiaro il diritto a costruire una didattica delle scienze, della matematica-ad esempio- dove l'attualismo doveva cedere più facilmente il passo alla forza del Numero, è ancora una battaglia da vincere quella per affermare il diritto ad esistere di una didattica della poesia.
Pochi elementi qui saranno da riportare - lasciando approfondimenti, conseguenzialità ed esempi ad un secondo prossimo intervento.
In primo luogo una didattica della poesia sembra parente di quella ricerca di integrazione fra istruzione ed educazione, di cui scrive Gerwald Wallnofer nell'introdurre "Società della co-municazione e scuola" di Franco Frabboni. Certo non può sorgere da quegli approcci mutilanti che lui definisce, riprendendo la ricerca internazionale, come basati o sulla trasmissione rigida dei saperi, oppure sulla transazione, sul mitizzato "star bene a scuola."
L'integrazione di aspetti di istruzione con l'irrinunciabile riferimento alle meta educativa più generale può condurre utilmente un passo più avanti.
In primo luogo ad affermare la necessità che l'insegnamento della poesia si rivolga sia ad una sorta di alfabetizzazione primaria circa le conoscenze di contesto, sia ad una forte individualiz-zazione e ad un interscambio emotivo e creativo che riconduca alla capacità e al potere della poesia di formare l'individuo liberando la sua intelligenza.
Proseguendo su questo piccolo “codice binario”, ma non antinomico, alla coppia “istruzione/educazione”, ed alla susseguente coppia “conoscenza contestuale /conoscenza più ravvicinata del poeta, può seguire ancora la, ben nota a chi legge, coppia: classe/laboratorio. Nel definire un progetto didattico sarà possibile dunque aver cura di avvicinare dapprima alla conoscenza dei termini e dei riferimenti di cui un poeta e una poesia sono parte, e forse ancor prima delle parole che il poeta usa.
La conoscenza dei primi elementi del sapere che sono inerenti agli autori ed ai testi non deve essere scambiata per la “pubblicazione di una sentenza”, per un giudizio pregresso, deve essere la base per una padronanza nella lettura diretta e più autonoma da parte di chi studia.
Infne si può, come spesso avviene, prevedere il superamento del solo momento frontale inse-gnante/testo/studente in un percorso di più intensa “comprensione”, in un interscambio -a quel punto davvero intenso e fondato- di emozione e ri-creazione, in un laboratorio elaborativo di nuove scritture.
Laddove è possibile in un ambiente favorevole e predisposto, un sogno sarebbe un' aula didat-tica specializzata, una "aula aperta della poesia" dove gli elementi siano al servizio di una più diretta compenetrazione con il testo, ed anche al gioco e alla prova della “traduzione”, e della nuova scrittura..
Oggi, in parallelo con il recupero con troppe ambiguità dell’imparare a memoria (per aumen-tare le parole conosciute, si dice), si sostiene sovente la scrittura creativa come una prova in se valida e sostitutiva di conoscenza, lettura e comprensione dei poeti.
Non ci pronunciamo sulle virtù intrinseche ai laboratori di scrittura creativa ma, certo, se la prova fosse all’interno ed al termine di un percorso nella poesia il loro valore potrebbe essere più certo.
Non si creda, quasi al termine di un intervento come il presente, certamente rivolto ad una criti-ca di quella “dimissione dalla pedagogia” che sembra oggi così di moda, che si voglia indicare l’approdo ad una fredda ed arida proposta organicistica e rigidamente contestualizzata della poesia.
Al contrario, ancora una volta, una "sana e robusta" programmazione didattica potrà rappre-sentare l'antidoto anche ad un ruolo della mediazione docente tutta tesa alla spiegazione per pa-rafrasi, alla vivisezione del testo fino a smarrirne senso e bellezza.
Torniamo all'Infinito. Riconoscere in Leopardi la forma, imparare a connetterlo con il suo tem-po e con il modo che il suo tempo ha avuto di esprimere l'universale di perenni sentimenti umani, di cui è stato il più alto esempio, ebbene: tutto ciò esclude il risolversi in una mistica fredda della conoscenza.
Andiamo per triadi, come il vecchio Hegel, per farci capire- per carità ! - non per convinta ideologia.
Al conoscere e all'emozionarsi dovrà essere favorito dall'insegnante, il momento del "com-prendere", appunto come predetto: "il prendere dentro".
Ancora una triade: alla pratica dell'attimo, e alle ragioni dell'analisi dovrebbe, è il nostro avviso, succedere una sorta di "grammatica della fantasia".
Si ricorderà: è un famoso titolo rodariano, e Gianni Rodari e il suo, oggi dimenticato, inno-cente “marxismo dell'anima” può ancora dire moltissimo. Può far ragionare su un modo di fa-re scuola con la poesia dove la programmazione sia matrice di libertà , dove lo schema del progetto dell'insegnante tenda alla cura e all'allargamento delle opzioni del discente, e –infine- dove la creatività sia davvero resa possibile da una estensione delle facoltà di parola e di pen-siero.
Gli antichi, De Sanctis, Montale, un pizzico di Hegel, Rodari: abbiamo disseminato, come Pollicino, il nostro percorso di sassolini molto impegnativi,.
Sia permesso a sostegno di una tesi non popolarissima quale quella che andiamo sostenendo concludere con l'aiuto di Mario Luzi.
Il poeta, nella sua ultima generazione di vita, aveva raggiunto una particolare volontà di testi-monianza, una saggia non acquiescenza ad un presente smarrito e incapace di teoria ed impe-gno civile.
Leggiamolo in una delle ultime interviste: "Il fine dell’insegnamento della poesia nella scuola deve trasformarsi in uno strumento di riflessione sui grandi problemi che l'umanità ha affron-tato nel suo cammino culturale. Lo studio della poesia, infatti, va presentato come uno dei momenti più formativi per una discussione sui grandi temi umani. La poesia...(rimanda a una) conoscenza molteplice, complessa, multiforme dell'uomo e della sua storia, del modo con cui un autore ha interpretato il modo unico e originale di abitare la terra proprio e dell'epoca in cui è vissuto. Grande poeta, infatti, non è chi sa padroneggiare tutti gli strumenti linguistici, ma chi attraverso il possesso di tali strumenti ha saputo e sa interpretare un preciso momento storico e culturale."